
Forse l’abbiamo scampata. Tra fine febbraio e inizio marzo, tutte le agenzie di stampa hanno lanciato una notizia sensazionale: dal 2035, stop alla produzione di veicoli equipaggiati con motore termico.
In altre parole, stop alla produzione e all’immatricolazione di scooter, moto, auto, furgoni e perfino camion con motore benzina e diesel.
Stando a questa norma, la mobilità pubblica e privata europea sarebbe dovuta diventare al 100 per cento elettrica.

Una decisione di buon senso, pensando all’ambiente e ai recenti inquietanti fenomeni legati al cambiamento climatico, ma allo stesso tempo così divisiva da non trovare, almeno per ora, il definitivo via libera da parte del Parlamento europeo.
Quindi al momento tutto resta come è. Ci si limiterà alla progressiva introduzione di norme sempre più restrittive per la circolazione dei vecchi motori termici. È una buona notizia.
Se da una parte l’elettrico è l’unica tecnologia in grado di sostituire il vecchio motore a scoppio, dall’altra si tratta di una soluzione con ancora molti limiti e passare a una esclusiva mobilità elettrica nel 2035 rischierebbe di creare molti problemi, anche sotto il profilo occupazionale.

1. Autonomia limitata. Tempo e potenza

Il motore termico, cioè quello che funziona grazie alla combustione di benzina o gasolio, è stato inventato verso la metà del 1800.
Da allora nulla è cambiato nel suo funzionamento, anche se quasi due secoli di sperimentazione hanno fatto sì che i moderni motori fossero più efficienti, i consumi si riducessero e le prestazioni migliorassero.
Soprattutto hanno consentito che le moderne automobili raggiungessero autonomie di migliaia di chilometri. È proprio su questo punto che il confronto con le auto elettriche risulta impietoso.

Oggi le auto elettriche più performanti hanno autonomie inferiori ai 500 km. A differenza di un’auto a benzina o diesel, inoltre, la ricarica dura decisamente di più del tempo necessario per fare il pieno.
Sulla velocità di ricarica non si possono prevedere, almeno al momento, grandi margini di miglioramento. Gli elementi da prendere in considerazione sono due. Da un lato c’è la capacità della batteria e dall’altro c’è la potenza disponibile in ricarica.
Per comprendere questo concetto basta pensare che l’energia è il prodotto tra potenza e tempo. Per ottenere la stessa quantità di energia in un tempo minore, è necessario aumentare la potenza.
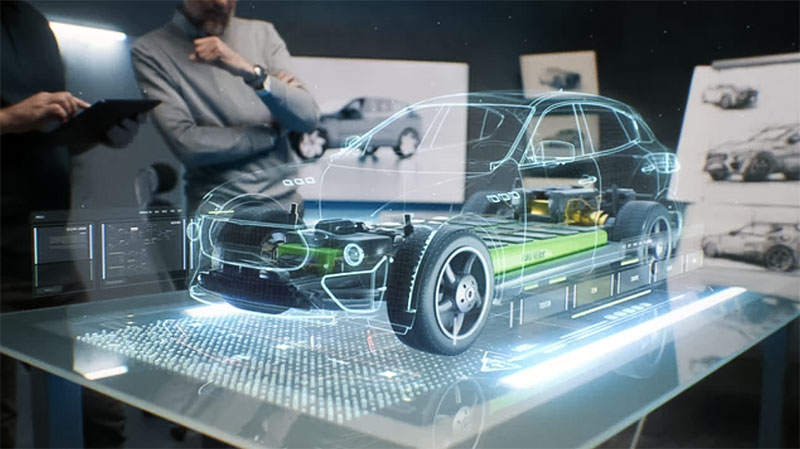
Prendiamo il caso di un comune impianto domestico, dove la potenza è di 3 o 6 kW e immaginiamo di avere un’auto elettrica performante, con un pacco batteria da 100 kWh. Con i 6 kW di potenza disponibile, per caricarla al 100% saranno necessarie circa 16 ore.
Sempre che sia possibile sfruttare tutta la potenza della rete. In una casa normale, con frigoriferi, computer, televisioni ed elettrodomestici vari collegati, ciò è praticamente impossibile.
L’unica possibilità è installare un secondo contatore dedicato solo alla ricarica, magari di potenza superiore. Con un certo aggravio di costi.

2. Colonnine di ricarica

L’alternativa è quella di utilizzare una colonnina di ricarica pubblica. Anche qui, però, ci sono delle differenze.
I CPO, ossia i Charging Point Operator, sono l’equivalente moderno dei vecchi benzinai, o meglio delle compagnie che possedevano le pompe di benzina.
Sono i CPO, infatti, che si occupano di realizzare le infrastrutture necessarie all’installazione delle colonnine di ricarica per le auto. A seconda della potenza, le colonnine installate dai CPO garantiscono una ricarica più o meno veloce.

Le più lente hanno potenze da 22 kWh e funzionano in corrente alternata. Dal momento che le batterie delle auto funzionano in corrente continua, però, tra la colonnina di ricarica e la batteria è necessario un elemento chiamato “raddrizzatore” che può rappresentare una sorta di collo di bottiglia non permettendo di sfruttare a pieno la potenza erogata dalla colonnina.
Le cose cambiano quando si passa alle colonnine di livello superiore. Quelle “veloci” e le “ultra veloci”, con potenza fino a 350 kW, erogano infatti energia in corrente continua e, per tornare all’esempio precedente, l’auto che prima impiegava circa 16 ore a ricaricarsi alla colonnina di casa, con una potenza disponibile di 300 kW arriva al 100% in circa 20 minuti.

Corrente elettrica continua o alternata? La corrente elettrica è provocata dal movimento degli elettroni attraverso un circuito elettrico. Esistono due tipi principali di corrente elettrica: la corrente continua (DC) e la corrente alternata (AC).
La corrente continua è quella generata da pile e batterie. Di conseguenza, tutti i dispositivi che esse alimentano, tendenzialmente, sono in corrente continua.
La corrente alternata, al contrario, viene utilizzata soprattutto per la distribuzione di energia elettrica, attraverso reti di alimentazione ad alta tensione, in quanto è più adatta al trasporto su lunghe distanze.

3. Potenza richiesta e via ai cantieri

Attenzione, però. Stiamo parlando di colonnine di ultima generazione, ancora rare e con una potenza nominale importante. 300 kW, infatti, sono l’equivalente di circa 100 utenze domestiche.
Per la loro alimentazione è necessaria una connessione in media tensione con la rete di distribuzione pubblica e la realizzazione di una cabina detta “secondaria”, delle dimensioni di un piccolo container, il cui prezzo varia tra i 40 e i 70mila euro», puntualizza il nostro esperto.
Un investimento notevole, ma inevitabile per realizzare colonnine di ricarica che garantiscano la completa transizione alla mobilità elettrica. Non basta. A monte, devono essere realizzate nuove cabine “primarie”.
E qui le cose sono ancora più complicate. La realizzazione di queste infrastrutture richiede tempo e ulteriori risorse economiche. Prendiamo l’esempio di Milano, la città più “avanti” nello sviluppo di politiche legate alla mobilità elettrica.
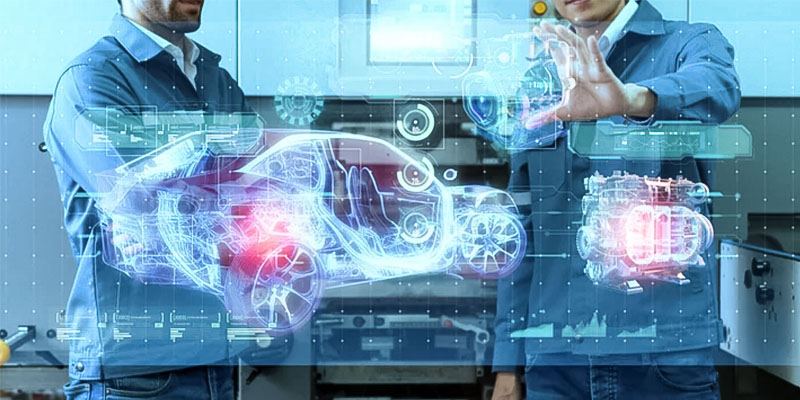
L’obiettivo che si sono posti i tecnici è quello di arrivare a realizzare una cabina primaria all’anno. Una cabina primaria, infatti, non è una piccola struttura ma un edificio di 2-3.000 metri quadri del costo di parecchi milioni di euro.
Tutte queste cabine vanno poi collegate tra loro e con la fonte dell’energia. In una città come Milano, per esempio, questo significa ribaltare interi quartieri per potenziare le reti esistenti. Cosa potrebbe succedere nel resto d’Italia e in particolare nei centri minori? In molti casi la creazione di un’infrastruttura di questo tipo sarà impossibile. Non nel breve o medio periodo.
Anche ipotizzando che sia possibile creare l’infrastruttura, non si può ignorare un altro problema. Oggi l’Italia non può produrre energia sufficiente per alimentare questa transizione. Per lo meno, non è in grado di produrre così tanta energia “pulita”.

È bene ricordare che al momento circa la metà dell’energia elettrica prodotta nel nostro Paese deriva da centrali a gas. In altre parole, se non si interviene anche in questo ambito, il rischio è quello di ridurre le emissioni di auto e camion ma di aumentare quelle delle centrali termiche.
Del resto l’Italia ha detto no all’uso dell’energia nucleare già diversi anni fa. Anche nell’ipotesi di riaprire quel dibattito, saremmo in grave ritardo per realizzare nuovi impianti.
La vera sfida sarà fare piani che prevedano l’impiego di un mix di rinnovabili: eolico e solare soprattutto con un aiuto delle centrali idroelettriche. Siccità permettendo.
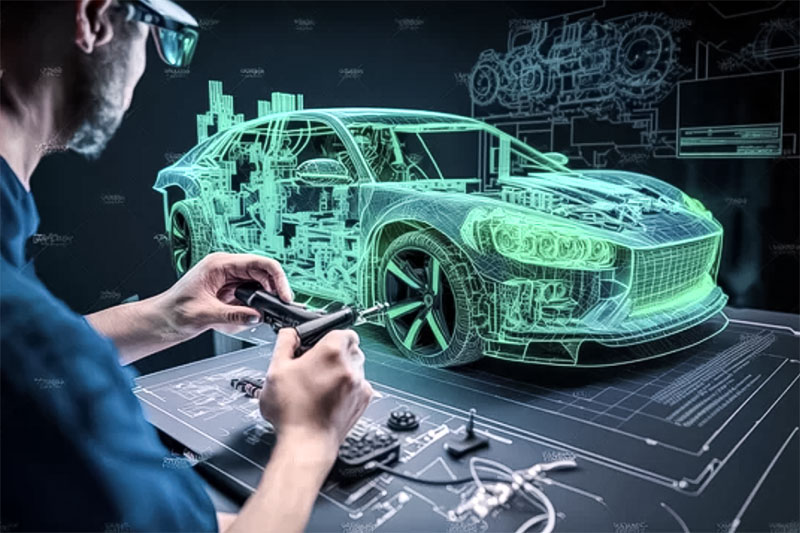
4. Reti smart e batterie più efficienti

Se incrementare la produzione di energia può rappresentare un problema, quello che i tecnici stanno iniziando a sperimentare è come rendere più efficiente la rete esistente, sfruttando al meglio le risorse disponibili e limitando gli sprechi.
La rete elettrica italiana comincia ad avere una certa età. La maggior parte degli impianti risale agli anni ’70 o ’80.
Grazie all’informatica e alle nuove tecnologie bisogna rendere le reti più smart, ossia più intelligenti: ad esempio convogliando la potenza là dove c’è maggiore richiesta a discapito di utenze che in quello stesso momento non la richiedono (il cosiddetto demand-response). Una soluzione abbastanza semplice che razionalizzerebbe notevolmente l’uso delle risorse disponibili.

Quelli esposti fin qui, però, rappresentano solo la metà dei problemi. Altre sfide riguardano le batterie. Dall’efficienza di questi elementi, infatti, dipende quasi tutto.
La domanda che sorge spontanea è: ma se l’intera mobilità europea dovrà un giorno essere elettrica, saremo in grado di produrre sufficienti batterie per tutte le auto? E soprattutto, che impatto avrà tutto ciò sull’ambiente?
Le batterie delle auto funzionano grazie alla reazione chimica prodotta da alcuni elementi. Stiamo parlando delle cosiddette “terre rare”. Elementi preziosi come il litio, il cobalto o il nichel che, a discapito del nome, non sono “rari” in termini di quantità ma che richiedono investimenti importanti per essere estratti.

Un altro problema deriva dal fatto che la maggiore concentrazione di questi elementi si trova in parti del mondo “complicate” da un punto di vista politico, come la Russia e alcuni stati del Centro Africa, i cui giacimenti sono in larga parte controllati dalla Cina.
Di positivo c’è il fatto che già oggi le batterie sono riciclabili e che buona parte delle terre rare utilizzate per la loro produzione può essere recuperata per essere impiegata nella costruzione di nuove batterie.
Si tratta dunque di un circolo virtuoso che permette di incrementare la produzione di nuove batterie senza eccessivi sforzi.

5. Economia di scala

Resta il problema del costo. Nei prossimi 15 anni la tecnologia farà passi da gigante ed è facile immaginare che presto ci saranno accumulatori più efficienti e più economici.
Per ora, per abbassare i costi, si può solo lavorare su grandi economie di scala. Come ha fatto Tesla, per esempio, che ha creato delle vere e proprie Gigafactory per ridurre i costi di produzione delle sue batterie.
In conclusione, se da una parte non si possono più ignorare i messaggi che giungono dall’ambiente, dall’altra è evidente che una transizione così importante, come quella verso una mobilità 100% elettrica, non può essere affrontata a cuor leggero.

Altrimenti il rischio è che la cura sia giusta... ma che finisca comunque con l’uccidere il paziente.
Lo stop ai motori termici cancellerebbe in Italia 70mila posti di lavoro. Subito dopo l’annuncio dello stop alla produzione di auto benzina e diesel dal 2035, l’industria italiana (e non solo) ha sollevato perplessità sulla sostenibilità sociale della manovra.
Un cambiamento epocale come questo è destinato a portare cambiamenti significativi nel mondo del lavoro, in Italia e più in generale in tutta Europa. Le ripercussioni negative riguardano soprattutto i lavoratori delle industrie.

Con la drastica riduzione della domanda di auto termiche, infatti, il settore dell’auto non potrà che rispondere con la chiusura, o il ridimensionamento, delle fabbriche.
Stando ai dati di CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) la perdita di posti di lavoro in Europa potrebbe sfiorare le 300mila unità, di cui 70mila in Italia.

Di contro, però, c’è anche chi stima che l’aumento della produzione di auto elettriche potrebbe avere effetti positivi sul mercato del lavoro. Soprattutto nel settore delle tecnologie e la ricerca. Piccoli numeri, però. Di sicuro non sufficienti a riequilibrare la bilancia.
Per mitigare queste ripercussioni negative, i governi dell’Unione Europea, oltre a ripensare a una roadmap verso l’elettrico con tempi più realistici, dovranno lavorare allo sviluppo di politiche di formazione e riqualificazione per i lavoratori.
Oltre alla creazione di nuovi incentivi per le imprese che si impegnano nella produzione di tecnologie a basse emissioni.






