
«L’empatia è l’arte di mettersi nei panni di qualcun altro e di vedere il mondo attraverso i suoi occhi, è lo strumento più potente che abbiamo per capire la vita degli altri» diceva Roman Krznaric.
Quest’anno, nel mese di gennaio, la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di legge n. 2493, il cui progetto prevede «l’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale».
Per tre anni, la scuola italiana potrà sperimentare una nuova strada nella quale ogni ora di lezione, che sia di matematica, di geografia o di educazione fisica, avrà, dopo la necessaria formazione dei docenti, un elemento trasversale in più: la competenza empatica e relazionale.

1. HARD SKILLS E SOFT SKILLS

Ma che cosa sono esattamente le “competenze non cognitive”? A tutti noi sarà capitato di affrontare un colloquio di lavoro presentando il proprio Curriculum Vitae.
In primo luogo ci viene chiesto “che cosa sappiamo”, ovvero qual è la nostra qualifica, il nostro percorso formativo, le esperienze lavorative, ciò che abbiamo studiato dunque, di facile reperibilità poiché certificato da attestati, diplomi, corsi, lauree, e così via.
Le competenze tecniche necessarie per presentarsi a un determinato colloquio di lavoro variano a seconda del ruolo specifico richiesto da quella azienda. Se la mia azienda ha bisogno di un traduttore che conosca il giapponese, la competenza tecnica imprescindibile (cioè specifica) è che il candidato lo abbia studiato.

Le competenze richieste possono dunque essere “specifiche”, come in questo caso, ma anche “non specifiche”, quando ad esempio la domanda prevede la conoscenza delle tecnologie, come il temuto “pacchetto Office”, o la padronanza della lingua inglese che vede purtroppo noi italiani, ancora un po’ indietro rispetto ad altri paesi in Europa e nel mondo. Le Hard Skills sono dunque tutte quelle competenze tecniche e cognitive che esibiamo nel Curriculum attraverso i nostri attestati o precedenti esperienze lavorative.
Ma cos’altro deve valutare una azienda, durante la selezione del personale? A parità di Hard Skills, cosa fa la differenza? Ecco che entrano in gioco le Soft Skills. Il “sapere” non può prescindere da altri due elementi fondamentali: il “saper fare” e il “saper essere”. Il “saper fare” è, in poche parole, il passaggio dalla teoria alla pratica.

La conoscenza del giapponese, se ci riferiamo al precedente esempio, da sola non basta, poiché dobbiamo essere in grado di riuscire, ad esempio, a tradurre simultaneamente senza farci prendere dall’ansia. Il saper fare è dunque il modo in cui utilizziamo la nostra conoscenza specifica. Ma esiste una terza “competenza”, più difficile da certificare, che è quella del “saper essere”, che rientra nel mondo delle Soft Skills o Life Skills.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1993 ha stilato un decalogo in cui descrive in questo modo le Life Skills: «Con il termine “Skills for life” si intendono tutte quelle skills (abilità, competenze) che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana. La mancanza di tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress [...] Per insegnare ai giovani le Skills for life è necessario introdurre specifici programmi nelle scuole o in altri luoghi deputati all’apprendimento».

Le Life Skills elencate dall’OMS sono:
1. Decision making (capacità di prendere decisioni)
2. Problem solving (capacità di risolvere i problemi)
3. Pensiero creativo
4. Pensiero critico
5. Comunicazione efficace
6. Capacità di relazioni interpersonali
7. Autoconsapevolezza
8. Empatia
9. Gestione delle emozioni
10. Gestione dello stress
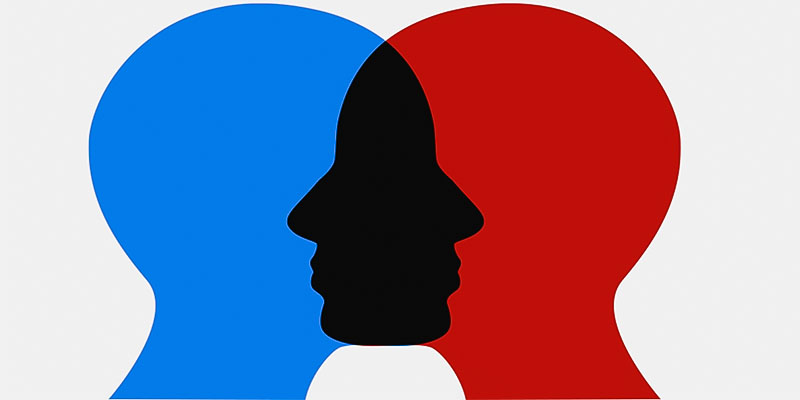
Le Life Skills o Soft Skills sono dunque tutte quelle capacità trasversali che rappresentano ciò che siamo al di là delle nostre competenze tecniche; si basano sulle nostre capacità di metterci in relazione e sulla conoscenza di noi stessi.
Al mondo del lavoro oggi non bastano più diplomi o lauree, ma sono fondamentali per la creazione di una squadra anche tutte quelle sensibilità emotive, di relazione, di creatività che non si possono apprendere nei libri. Sono le “competenze non cognitive” a cui si riferisce il Disegno di Legge succitato, appena approvato.
Ciò che fa “grande” il team di Freedom, ad esempio, non sono solo le abilità specifiche di ogni singolo componente, ma anche e soprattutto la capacità di ognuno di “fare squadra”, la resilienza nel risolvere gli imprevisti, la motivazione, la creatività e l’empatia: ovvero, il sapersi mettere nei panni degli altri.

2. SAPER ASCOLTARE
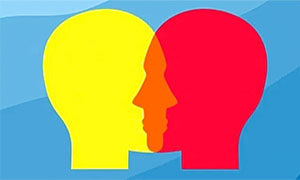
Il significato più conosciuto che attribuiamo all’empatia è dunque quello che ci vede capaci di metterci nei panni degli altri.
Ma prima di affermare che siamo persone empatiche, dobbiamo fare un passo indietro. Occorre innanzitutto imparare ad ascoltare empaticamente l’altro, in modo da poterci così mettere nei suoi panni.
Siamo sicuri di sapere cosa significhi realmente ascoltare? Sappiamo davvero restituire un significato corrispondente a ciò che l’altro ci comunica sia a livello verbale sia a livello non verbale?
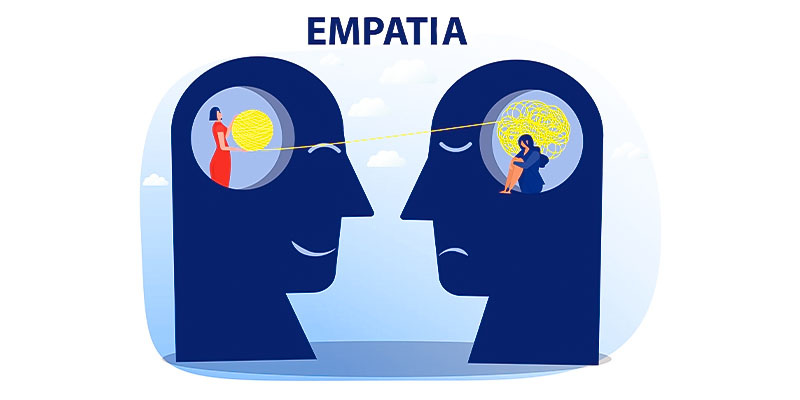
Ci sono due tipologie di ascolto: l’ascolto passivo e l’ascolto attivo. Non mancano di certo esempi nella vita di ognuno di noi in cui ci siamo sentiti non ascoltati: dagli insegnanti, dal proprio partner, dai colleghi, dai figli. Quante volte abbiamo detto all’altro «Ma mi stai ascoltando? dove sei con la testa?».
Proviamo a riflettere un momento su ciò che ci ha fatto sentire non ascoltati... forse, mentre stavamo parlando ci siamo accorti che il nostro interlocutore guardava continuamente il telefono o che si lasciava distrarre da una qualsiasi minima interferenza esterna. O forse, mentre parlavamo, il nostro ascoltatore non ci guardava, non annuiva o dissentiva, non interveniva oppure interveniva troppo.
Ecco, questo è proprio l’ascolto passivo, un ascolto privo di empatia. È difficile da ammettere, ma spesso siamo cattivi ascoltatori. La capacità di ascolto empatico, o attivo, non è facile e richiede tanta attenzione.

Nella Programmazione Neuro Linguistica, meglio conosciuta come PNL, (disciplina che studia i processi di comportamento e di comunicazione) si utilizzano delle tecniche specifiche per facilitare il contatto empatico con l’altro. Una di queste è il cosiddetto “rapport” che utilizza il rispecchiamento come collante per l’instaurarsi di una buona interazione interpersonale.
Con la tecnica del rapport, ad esempio, possiamo riflettere la postura dell’altro, mettendoci con il corpo nella sua identica posizione, oppure potremmo usare il suo stesso tono di voce, la sua gestualità. Ma attenzione, fare da specchio non deve essere un’imitazione grottesca dell’altro, bensì una chiave per entrare in risonanza empatica e per accrescere la fiducia reciproca.

Se osservassimo da lontano due innamorati, scopriremmo senza dubbio che inconsciamente essi assumono la stessa posizione sulla sedia: avranno le braccia appoggiate sul tavolo allo stesso modo e parleranno con la stessa frequenza sonora. L’ascolto attivo è scambio, interazione con l’altro, riformulazione («se ho capito bene hai detto che...»), è contatto visivo, rispecchiamento corporeo, richiesta di chiarimento, domanda, assenza di giudizio.
L’ascolto empatico richiede un’attenzione totale, un trasporto, un metterci tutto di noi stessi, senza però prevaricare sull’altro. Converremo insieme che non è cosa semplice, né scontata. E anche se va detto che non possiamo interagire sempre con questi livelli di attenzione, siamo ancora sicuri di essere dei buoni ascoltatori empatici?

3. METTERSI NEI PANNI DELL’ALTRO

Un antico proverbio dei nativi americani Sioux dice: “non giudicare il tuo prossimo finché non avrai camminato per due lune nei suoi mocassini”.
In E.T. l’extraterrestre (famosissimo film di Spielberg del 1982), il piccolo Elliot entra in comunicazione empatica con l’alieno riuscendo a “provare” e a “sentire” ciò che, contemporaneamente, nonostante la distanza fisica, “provava” e “sentiva” E.T.
Non esiste una definizione di empatia unica o globalmente condivisa dagli studiosi, che nei secoli ne hanno elaborato il concetto. Nell’antica Grecia, la parola empàtheia si riferiva a quella passione circolante tra l’artista e il suo pubblico come un entrare nelle emozioni altrui facendole proprie.
Il concetto di empatia è stato poi ripreso, elaborato, teorizzato da filosofi, sociologi, psicologi, artisti, scienziati. Empatia, così come la intendiamo oggi, deriva dal termine tedesco einfühlung, quel “sentire dentro” come immedesimazione e riconoscimento dei vissuti emotivi dell’altro. Tutti sono d’accordo però nell’affermare che l’empatia ha permesso all’uomo di evolversi, ne ha favorito le relazioni e la socialità; è una forza vitale innata tramite la quale tutto ciò che l’essere umano esperisce può essere compreso e condiviso dagli altri.

L’empatia è un’attitudine umana e, come vedremo, ha persino una base biologica. Empatia non è però né simpatia, né amicizia, né gentilezza... facciamo attenzione a non confonderci! L’empatia, infatti, spesso viene confusa con tutti quei fenomeni “simpatetici” che tendono ad attirarci verso l’altro, facendoci dire che “siamo empatici” quando ci sentiamo vicini a qualcuno o, al contrario ad allontanarci, quando qualcuno davvero non ci piace, affermando che proprio “non riusciamo a provare empatia”.
Purtroppo o per fortuna non è così semplice. L’empatia richiede un grosso impegno mentale e attinge alla nostra intelligenza emotiva. Perché? Perché per essere empatici, occorre in primo luogo saper ascoltare in maniera attiva. E, come abbiamo appena visto, l’ascolto empatico dell’altro non è così naturale. In secondo luogo, chi prova empatia si astiene da qualsiasi giudizio sull’altro e non proietta i propri contenuti emotivi, ma accoglie quelli che l’interlocutore comunica.
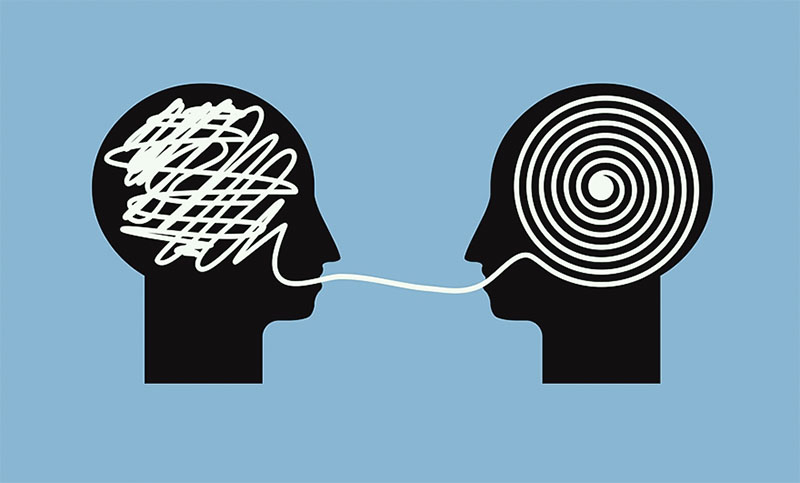
Inoltre, occorre possedere un’importante capacità di introspezione, di conoscenza delle proprie emozioni, per poterle poi “riconoscere” anche nell’altro. Quanto più è ricco il nostro bagaglio emozionale, tanto più facile sarà vestirci delle emozioni altrui. Non solo, le persone empatiche, non si sostituiscono all’altro, non “iper-empatizzano”, non si identificano, ma riescono a mantenere un buon grado di differenziazione e la giusta distanza tra il sé e l’altro da sé.
Tornando ai due esempi iniziali, potremmo dire che per mettersi nei panni dell’altro occorre, come dice il proverbio Sioux, indossare per un po’ le sue scarpe (con un buon ascolto), senza giudizio. Solo così potremmo davvero entrare in risonanza empatica e riuscire a sentire e comprendere, senza simbiotica identificazione, le emozioni di chi ci sta vicino, anche se non “parla” la nostra lingua, come avviene tra il piccolo Elliot ed E.T (foto sotto).

4. PRATICARE L’EMPATIA

Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein (1891- 1942), è stata una filosofa e una monaca dell’ordine delle Carmelitane Scalze proclamata santa da papa Giovanni Paolo II nel 1998.
Di origine ebraica e convertita al cattolicesimo, la sua intelligenza sorprendente e il suo pensiero hanno donato un contributo determinante sia in campo spirituale sia filosofico al mondo intero.
Edith Stein fece dell’empatia, il fulcro centrale delle sue ricerche, identificando tre gradi del processo empatico:
1. EMERSIONE DEL VISSUTO: quando una persona cara sta attraversando un momento difficile e ci poniamo in ascolto, ciò che percepiamo dalla sua narrazione non è solo il contenuto verbale, ma prestiamo attenzione anche alle espressioni del volto, ad esempio, o alla sua voce, intuendo il suo stato emotivo. In questa prima fase, emerge il vissuto dell’altro e noi lo sentiamo e lo identifichiamo. Lo vediamo da ciò che abbiamo osservato attentamente durante l’ascolto.
2. ESPLICITAZIONE RIEMPIENTE: dopo che il vissuto è emerso e lo abbiamo sentito, esso non sarà più solo il racconto doloroso della persona cara, cioè non sarà più un “oggetto” bensì diventerà parte di noi, o meglio, noi entreremo nel vissuto dell’altro, sentendolo come nostro. L’attenzione è sullo stato d’animo che sentiamo, pur sapendo che non ci appartiene.
3. OGGETTIVAZIONE COMPRENSIVA: questo è il vero momento empatico, in cui le emozioni dell’altro che abbiamo sentito come nostre escono da noi nuovamente, in modo da riuscire a vederle ancora come “oggetti”. È proprio quando riusciamo a distaccarci o “oggettivare” il sentire dell’altro che possiamo davvero parlarne, offrendo infine il nostro aiuto, poiché abbiamo compreso realmente, ossia empaticamente, il dolore e il sentimento di chi ci è caro. Siamo ancora sicuri di saperci mettere nei panni degli altri?
Nella foto sotto, Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein.

5. I NEURONI SPECCHIO

La sera del 9 luglio del 2006 tutti gli italiani se la ricordano bene: Italia-Francia, finale dei mondiali di calcio, rigori.
Proviamo a immergerci nuovamente negli attimi che precedevano ogni tiro: sicuramente, non era solo il caldo a farci sudare!
Tutti sentivamo la tensione, l’adrenalina, il tremore, pur stando seduti sul nostro divano. Ciò che molti di noi non sanno è che in quei momenti erano al lavoro i nostri neuroni-specchio!
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, un gruppo di ricercatori dell’Università di Parma, coordinato da Giacomo Rizzolatti, scoprirono, durante esperimenti sui macachi per studiare i neuroni specializzati nei movimenti della mano, che un’area particolare del cervello si attivava sia quando le scimmie compivano una determinata azione, sia quando vedevano compierla da altre scimmie o anche dai ricercatori stessi.

Qualche anno dopo, lo stesso gruppo confermò la presenza degli stessi neuroni anche nell’uomo. Sono quelli che vengono definiti “neuroni specchio”, che si attivano nell’uomo non solo quando si compiono azioni ma anche quando si esprimono emozioni.
I neuroni specchio inoltre non si limitano solo a rispecchiare le esperienze altrui, ma riescono anche ad attribuirne un significato. Il nostro corpo, grazie ai neuroni specchio è in grado di riprodurre, sotto il livello della coscienza, ogni atto che vede compiere da altri, facendo sì che questo “rispecchiamento” ci consenta di rivivere e sperimentare sentimenti ed emozioni in una sorta di “simulazione incarnata”.
La tensione reale che stavano vivendo i giocatori in campo durante i rigori di quella indimenticabile serata del 2006 è stata codificata dai nostri neuroni specchio in questo magico meccanismo di simulazione, facendoci attivare un’intensa sudorazione o accelerando il nostro battito cardiaco poco prima del fischio dell’arbitro.
Viene da sé che neuroni specchio ed empatia viaggino insieme, in un percorso in cui ognuno di noi può regalare a sé stesso e agli altri momenti di comunicazione e di relazioni autentici.






