
Un “farmaco” che non è un farmaco, ossia non è un medicinale ma un prodotto privo di principio attivo.
In sostanza, una pillola zuccherata o un cucchiaio di acqua fresca, presentati al paziente come una terapia efficace.
Stiamo parlando dell’effetto placebo, utilizzato a livello comparativo durante gli studi clinici sui nuovi farmaci da mettere in commercio.
Il placebo è una medicina priva di principio attivo che si somministra ai pazienti come se fosse un vero medicamento.
Non è una novità, lo conoscevano anche gli antichi guaritori: sapevano che il primo rimedio alle malattie è la convinzione di guarire!
Sembrerebbe un inganno, ma non lo è: si tratta invece di un fenomeno complesso che esiste fin dalla notte dei tempi. Ritenuto basilare nelle terapie personalizzate, è sempre più studiato e molto promettente.
In alcuni casi, funziona. Sembra che l’effetto terapeutico sia prodotto da 11 geni del nostro DNA e gli scienziati stanno studiandolo a fondo.

1. Una storia che viene da lontano e che dipende (anche) dai nostri geni

La risposta al placebo ha radici che affondano nella neurofisiologia e nella genetica. Ha a che fare infatti anche con il nostro DNA.
Lo ha scoperto, nel 2015, un gruppo di scienziati israeliani, guidati dalla biologa molecolare Kathryn T. Hall, del Beth Israel Deaconess Medical Center della Harvard University, analizzando l’ampia letteratura scientifica sull’argomento.
Secondo la studiosa ci sono ben 11 geni implicati nella risposta al placebo, il che spiega perché l’effetto placebo non sia uguale per tutti, ma vari da un individuo all’altro.
Una sua maggiore comprensione appare cruciale perché offrirà la possibilità di approfondire le ragioni della variabilità individuale alle terapie e di rendere più accurati gli studi clinici, mettendo in evidenza le differenze fra farmaco e placebo.
L’utilizzo del placebo è noto all’uomo sin dall’antichità. Nel passato, la stragrande maggioranza delle terapie prescritte in tutto il mondo da stregoni, guaritori, sciamani e sacerdoti, ma anche dagli stessi medici, era basata sostanzialmente su di esso, ossia sulla speranza che il malato riponeva in maniera incondizionata nei confronti del guaritore e della cura.

Lo sa bene Fabrizio Benedetti, docente di fisiologia umana e neurofisiologia all’Università di Torino, direttore del Centro ipossia del Plateau Rosa e uno dei massimi studiosi al mondo di effetto placebo, che in più occasioni ha sottolineato quanto la «storia della medicina sia in realtà la storia del placebo».
Lo aveva intuito addirittura il filosofo greco Platone (IV-III sec. a.C.), che nella sua opera La Repubblica aveva messo in evidenza la necessità del medico di “compiacere il malato, anche attraverso la menzogna”, cioè utilizzando qualunque strumento avesse a disposizione (parole, pozioni e altro) per alleviare le sue sofferenze.
Il termine stesso “placebo” è di derivazione classica e la sua origine etimologica fa riferimento al tempo futuro del verbo latino placere. Letteralmente, dunque, placebo vuol dire: “sarò gradito, piacerò”.
Più avanti nel tempo, il vocabolo è stato introdotto nel linguaggio sanitario: lo fece nel 1772 il medico scozzese William Cullen, uno dei più autorevoli professori dell’Università di medicina di Edimburgo.
Allora però per placebo non si intendeva una sostanza totalmente priva di effetti, ma un basso dosaggio di un medicamento considerato inefficace in relazione alla gravità della malattia.
Sappiamo infatti che Alexander Sutherland, un medico anglosassone, proprio in quegli anni dichiarò di aver prescritto a un paziente una medicina che definì appunto “placebo” perché “era necessario prescrivere un farmaco a tutti i costi”, ma si sapeva che le cure non sarebbero state adeguate alla severità della patologia del suo paziente.

2. La storia attuale e il legame mente-corpo

Nel 2011 è stato condotto uno studio in Baviera dall’Associazione Medica Tedesca (BÄK) sull’utilizzo dell’effetto placebo in Germania presso i medici di famiglia.
Risultato? Addirittura l’88 per cento di loro manda a casa i pazienti con una “pillola di zucchero” per curare alcuni disturbi come quelli allo stomaco e alcune forme lievi di depressione.
Sempre in Germania, l’esito di questa ricerca avrebbe persino incentivato gli studenti di medicina a imparare a utilizzare il placebo per “massimizzare l’effetto delle cure, riducendo gli effetti collaterali”, come sostiene Robert Jütte, autore dello studio e membro della BÄK.
L’effetto placebo è stato e continua a essere un eccellente strumento per comprendere il funzionamento del cervello umano, i cui meccanismi sono stati studiati a fondo da molti scienziati, e sono stati confermati dalle tecniche di neuroimaging: esse sono in grado di visualizzare in maniera precisa le aree che si attivano (in particolare la corteccia prefrontale e il nucleo accumbens) quando viene somministrato un placebo, monitorando persino i singoli neuroni.
Numerosi sono stati gli esperimenti condotti da Fabrizio Benedetti, come quello eseguito nel 2017 sul Monte Cervino a 3.500 metri di altezza per capire fino a che punto l’effetto placebo potesse influenzare le funzioni vitali dell’organismo.
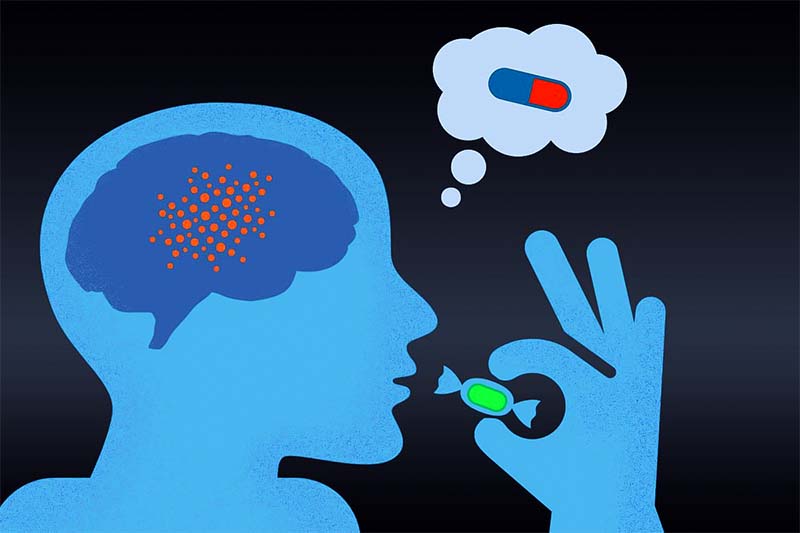
A quell’altezza la presenza di ossigeno nell’aria è molto più rarefatta (65 per cento in meno rispetto al livello del mare), il che comporta uno stato di ipossia. Benedetti e colleghi hanno però riscontrato che anche una bombola contenente ossigeno “finto” produce effetti analoghi a quelli dell’ossigeno vero, se i soggetti in esame pensano di respirarlo.
L’effetto placebo è importante nella sperimentazione di farmaci e vaccini! L’utilizzo del placebo è un cardine della sperimentazione clinica finalizzata a convalidare un farmaco o una nuova strategia terapeutica.
Le pubblicazioni scientifiche sull’argomento sono in costante crescita e le ricerche cliniche attive sono, al momento, più di 8.000 in tutto il mondo. In una ricerca clinica con placebo i pazienti vengono suddivisi in due gruppi: uno riceve il trattamento sperimentale, l’altro il placebo.
Idealmente sia il paziente sia il medico sono all’oscuro di quale trattamento venga somministrato (studio in doppio cieco) e per questo il placebo ha caratteristiche estetiche che lo rendono indistinguibile dal farmaco sperimentale.
Quando si propone a un paziente l’utilizzo du un placebo, questo ha già ricevuto un’autorizzazione da parte di un comitato etico, a garanzia dell’eticità del suo utilizzo per le finalità della ricerca.

3. L’effetto delle parole

Nel suo libro La speranza è un farmaco (Mondadori, 2018), Fabrizio Benedetti analizza l’impatto che le parole hanno sulla nostra psiche e sul nostro corpo.
Le parole costituiscono una parte sostanziale della cura e sono fondamentali per aumentare l’efficacia dei farmaci, ovviamente placebo compreso.
Anzi, l’effetto placebo ne è proprio la dimostrazione tangibile. «Le parole sono delle potenti frecce che colpiscono precisi bersagli nel cervello», scrive Benedetti, «e questi bersagli sono gli stessi dei farmaci che la medicina usa nella routine clinica».
Benedetti fa riferimento sia alle esperienze personali di somministrazioni di analgesici e oppioidi con o senza comunicazione al malato, sia a numerosi studi di altri scienziati che mettono in rilievo quanto sia meno efficace un farmaco (o placebo) se assunto inconsapevolmente o senza un rapporto empatico col proprio medico.
Del resto, spiega ancora Benedetti, «parole e farmaci hanno gli stessi effetti di azione. Le parole innescano gli stessi meccanismi della morfina. Anzi, sarebbe più corretto dire che sono i farmaci che attivano gli stessi meccanici della parola...
Nei primi ominidi e poi nell’Homo sapiens, l’interazione con i membri del proprio gruppo sociale era cruciale per il benessere dell’individuo, fino a sfociare nelle figure del guaritore e dello sciamano, che non avevano certo l’armamentario medico adeguato, ma potevano disporre delle parole e del contatto umano».
Dunque l’efficacia di un placebo è legata anche alla comunicazione e alle aspettative del paziente, nonché alle sue speranze che la terapia funzioni.
«Esiste una vasta area del cervello, i lobi prefrontali, responsabili dell’aspettativa di un evento futuro», afferma Benedetti. «La speranza può essere dunque vista come una funzione biologica».

4. C’è anche l’effetto nocebo

Quando si assume una medicina “finta” pensando che sia vera, si sperimentano gli effetti positivi del presunto farmaco, ma anche gli effetti collaterali.
È il cosiddetto effetto nocebo, cioè il verificarsi di eventi avversi: per intenderci, sono quelli comunemente elencati nel “bugiardino” di una medicina.
Testimonia quanto l’effetto nocebo sia una realtà tangibile l’esito di uno studio dell’Imperial College di Londra, pubblicato nel 2017 da The Lancet, una delle più prestigiose riveste scientifiche al mondo.
Stando a questa ricerca, gli effetti collaterali di un medicinale – vero o finto che sia – si verificano maggiormente qualora i pazienti siano informati circa i possibili effetti avversi.
«È l’effetto “nocebo”, fenomeno conosciuto da molti anni», afferma Peter Sever, professore di farmacologia all’Imperial College e autore principale dello studio.
«Quando i pazienti vengono avvertiti di possibili effetti collaterali di un farmaco, sono molto più propensi a lamentarsi della loro comparsa. Se invece non vengono informati, le segnalazioni sono meno frequenti».

L’effetto nocebo può essere anche indotto tramite suggestioni verbali negative. I medici sanno da tempo che le credenze dei propri pazienti, in alcuni casi possono essere deleterie per il loro benessere. La convinzione di avere una grave malattia per esempio può essere per certi versi più pericolosa della malattia stessa.
Allo stesso modo in cui gli stregoni voodoo riescono a condurre le loro vittime alla morte attraverso il semplice potere della suggestione, indurre qualcuno a pensare di essere malato può produrre i veri sintomi di una malattia.
Vomito, vertigini, mal di testa possono aver origine dalla semplice convinzione di aver ingerito una sostanza nociva o di aver ricevuto una maledizione. La cefalea causata da false credenze sull’uso del cellulare e malattie di massa psico-indotte sono esempi molto chiari di suggestioni negative collettive.

5. Il prezzo e la fede religiosa fa la differenza anche per il placebo

Uno studio del 2015 dell’Università di Cincinnati (Ohio, USA) pubblicato su Neurology, ha rivelato che anche nei placebo il prezzo fa la differenza.
Lo studio è stato svolto su pazienti con morbo di Parkinson, patologia per cui è stato dimostrato che l’assunzione di placebo può risultare efficace.
12 volontari sono stati informati che avrebbero ricevuto un nuovo farmaco in grado di potenziare la produzione di dopamina, un neurotrasmettitore presente in quantità insufficiente nei malati di Parkinson.
Sarebbero state loro iniettate due versioni differenti della sostanza, della medesima efficacia: una dal costo di 1.500 dollari e una da 100 dollari. In entrambi i casi, invece, ai pazienti sono state somministrate iniezioni di soluzione fisiologica, un placebo appunto.
Peccato che quanti hanno creduto di ricevere il farmaco più costoso abbiano avuto risultati nettamente migliori.

La fede religiosa può agire come un placebo! Il cervello di un credente è diverso da quello di ateo.
Le aree cerebrali della ricompensa vengono attivate da musica sacra, preghiere e da tutto ciò che sostiene la fede: ecco perché un credente che spera nella guarigione da una malattia anche attraverso un placebo è più disposto a crederci e quindi a giovarsene.
Lo dice Jeffrey Anderson, professore di radiologia alla University of Utah (USA), che ha studiato che cosa accade nel cervello umano durante un’intensa attività spirituale.
Ciò che ne è emerso è l’attivazione di diverse aree, in particolare del nucleo accumbens, struttura presente ad ambo i lati del telencefalo, responsabile del piacere sperimentabile in varie situazioni: musica, sesso, cibo, amore, droghe ecc.
Il nucleo accumbens è il bersaglio di molti farmaci e si attiva sia durante la pratica religiosa sia quando si assumono farmaci o un placebo.






